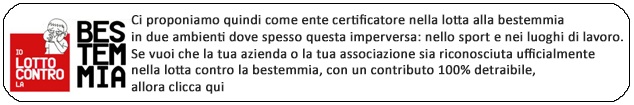Giovani e ludopatia: Alessia Marcaccio, è un problema enorme ma occorre lavorare sulla vera causa
Con l’espansione che il fenomeno del gioco legale ha avuto negli ultimi 20 anni è cresciuto anche l’allarme sulle ludopatie, una forma di dipendenza che purtroppo colpisce sempre di più anche i giovani. Chi la sviluppa fa però una fatica maggiore a riconoscere di avere bisogno di aiuto, anche perché il gioco – come l’alcol – è una sostanza legale. Per contrastarla le campagne proibizionistiche servono a poco, come non ha senso distruggere le vigne per eliminare l’alcolismo. Sia perché il gioco come attività in sé è una componente fondamentale per lo sviluppo della personalità; sia perché la dipendenza è il sintomo, ma le cause vanno cercate altrove. Di tutto questo abbiamo discusso con la dottoressa Alessia Marcaccio che ricopre le funzioni di direttrice clinica del Centro San Nicola.
Dottoressa Marcaccio, secondo lei, quanto sono allarmanti i dati sui minori che giocano d’azzardo?
Molto, anche perché portano subito a farsi un’altra domanda: questi dati passano per vari enti che li elaborano. Ma poi c’è un mondo sommerso, popolato da tutti quei soggetti che non si sono mai rivolti al servizio, non si sono mai rivolti a uno psicologo, non si sono mai rivolti a nessuno. Quanta gente c’è oggi che sta giocando e non rientra in quel dato? Oltretutto, occorre riportare questa ricerca al mondo in cui viviamo, dove le relazioni interpersonali sono sempre più rarefatte, e ci siamo abituati a rimanere chiusi in casa, o in una stanza, e ci limitiamo a interagire con un mondo virtuale che è fatto non solo di scommesse, ma anche di giochi di ruolo, di giochi virtuali. Il problema che sta a monte di questi dati è come funzionano oggi i nostri giovani: non sono in grado di avere un confronto faccia a faccia con un altro essere umano, ma riducono tutto al feedback dei social, alle connessioni che si hanno in quella realtà.
Questo problema, nel caso della ludopatia, è ancora maggiore, visto che il gioco su internet ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni. Viene da pensare che l’aumento dei giocatori giovani sia dovuto anche al fatto non è più necessario andare fisicamente in una sala… C’è la possibilità di prevenire il fenomeno?
Nel corso degli anni sono state lanciate tantissime iniziative di prevenzione. Basti pensare alle varie campagne contro le macchinette, le varie iniziative No-slot, zero-slot… A mio avviso, tuttavia, si tratta di iniziative abbastanza controverse. So di essere una voce fuori dal coro, ma non si può arrivare a distruggere le vigne per combattere l’alcolismo. L’obiettivo non deve essere quello di proibire, ma quello di educare a come si gioca in maniera responsabile, spontanea. Il gioco fa parte della nostra vita, è una componente importantissima, i bambini attraverso il gioco vanno a strutturare poi le loro prime relazioni interpersonali, e il gioco è uno strumento che permette di imparare a regolare le proprie emozioni. Quindi, occorre lavorare invece a monte, e capire per quale ragione una persona finisce con l’appoggiarsi al gioco. E la motivazione potrebbe essere nel fatto che l’adolescente si sente solo, non viene riconosciuto, non si sente ascoltato, non si sente parte integrante di un sistema familiare o di un sistema scolastico. Occorre fare un passo indietro, allora, e capire a quel ragazzo quali strumenti stiamo proponendo, che tipo di relazioni stiamo insegnando. Sempre più spesso i genitori – quando un bambino più piccolo si mette a piangere – non perdono tempo a capire quale sia il problema, ma gli mettono in mano un telefonino. E in questo modo sono i primi a insegnare ai figli che lo schermo, il giochino è il regolatore emotivo. A quel punto, ogni volta che si manifesta il sintomo, lo schermo diventa la soluzione.
Secondo una ricerca, le motivazioni che spingono a giocare sono tre: il desiderio di guadagnare denaro, la sfida, e la noia. Secondo lei, ci sono altre motivazioni?
Questi sono tre motivi molto validi, ma ci sono tantissime altre motivazioni che portano poi le persone a giocare. Io penso a tutte quelle persone che magari hanno una situazione finanziaria non ideale, che magari arrivano da un fallimento. Il Covid ci ha messo davanti alla precarietà, quanti imprenditori si sono tolti la vita perché si sono visti distruggere l’azienda in pochissimi mesi? Ma bastano la perdita del lavoro, o una separazione. Quanti padri vanno in difficoltà perché dopo una separazione devono versare gli assegni di mantenimento, prendere in affitto un’altra casa…
Che età hanno i ludopati che si rivolgono al Centro San Nicola?
Noi lavoriamo solo con maggiorenni, quindi non lavoriamo con questa fascia di adolescenti e preadolescenti. Per il resto non abbiamo un profilo tipo, abbiamo lavorato con pazienti di 25 anni come con pazienti di 60. Dipende dalla richiesta di aiuto, come viene fatta, a che punto della propria vita viene fatta, perché. Lavorare con un giocatore è in parte diverso rispetto al lavorare con chi ha una dipendenza sostanze. Anche perché è difficile che un soggetto accetti di rimanere al Centro, se ha delle situazioni debitorie: il giocatore cade nella trappola di pensare che basterà un’altra giocata, per vincere e sistemare i debiti. Il primissimo intervento – nel caso dei ludopati – è di creare una rete di professionisti – anche legali e commercialisti… – che lavorino sulla situazione debitoria. A quel punto si può intraprendere un percorso di recupero.
Può tracciare un profilo del paziente-tipo che si rivolge al Centro San Nicola?
Prevalentemente abbiamo un’utenza maschile, le donne fanno più fatica a chiedere aiuto perché c’è maggiore vergogna, c’è maggiore solitudine. La componente femminile rappresenta sempre una percentuale molto ridotta. Raramente abbiamo pazienti al di sotto i 20 anni, la maggior parte ha un’età che va dai 40 ai 60 anni. Lavoriamo con persone che hanno già una buona consapevolezza di aver un problema di dipendenza. E questo in un certo senso semplifica il percorso, perché non occorre lavorare tanto tempo sulla fase dell’ambivalenza e della frattura interiore, per arrivare all’accettazione della malattia.
I giocatori patologici sono più restii a ammettere la dipendenza, rispetto a altri soggetti?
Sì, osserviamo lo stesso fenomeno nel caso degli alcolisti. Fanno una fatica maggiore ad ammettere di avere un problema. Questo dipende anche dal fatto che alcol e gioco sono legali. L’idea generale è che la dipendenza sia quella dalle droghe. Invece i giochi e gli alcolici li troviamo ovunque: al supermercato, al negozietto sotto casa… è quindi difficile ammettere di avere una problematica.
Si sostiene generalmente che ludopatia e alcolismo abbiano dei tratti in comune, cosa li differenzia dalle altre dipendenze?
In realtà la matrice di tutte le dipendenze è la stessa, si cerca un’evasione da una realtà che non ci fa sentire a nostro agio, che non si riesce a gestire, che non si può tollerare. Il gioco, l’alcol, la droga etc. a quel punto diventano un regolatore emotivo, lo strumento per attivare i circuiti cerebrali dell’appagamento e della gratificazione. Ognuno sceglie poi la sostanza che gli garantisce una determinata sensazione: la cocaina esalta, l’eroina seda…
In un percorso di recupero il pericolo di ricaduta è maggiore nel caso del gioco d’azzardo?
Il pericolo di ricaduta è uguale per tutti. Stiamo parlando di una patologia che l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce cronica, progressiva e mortale. Già nel cronico è implicito il rischio di ricaduta, se non si utilizzano gli strumenti di cui abbiamo parlato. E il rischio è sempre elevato se il paziente torna a casa con la consapevolezza che il contesto che ha lasciato è rimasto lo stesso. Deve comprendere invece che dovrà essere lui stesso, o lei stessa, a costruire delle modalità di funzionamento diverse e quindi gestire in maniera diversa quel contesto. Anche per questo è fondamentale poter contare su una rete di sostegno, e attuare tutto quello che si è appreso durante il periodo in struttura. Più si rimane in questa rete – che può essere rappresentata anche da professionisti privati, a da gruppi di mutuo aiuto – più si interiorizzano il percorso di recupero e le skills per gestire le situazioni che spingevano a giocare.
I ludopati arrivano quando purtroppo è molto tardi, cioè quando hanno già perso somme ingenti e compromesso i rapporti familiari?
Non necessariamente, molti hanno ancora la famiglia accanto e – per quanto i familiari possano provare del risentimento – i rapporti sono rimasti solidi. Per altri la situazione è più compromessa, occorre ripartire da zero e ricostruire la fiducia in queste relazioni.